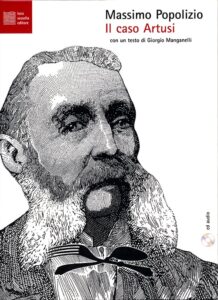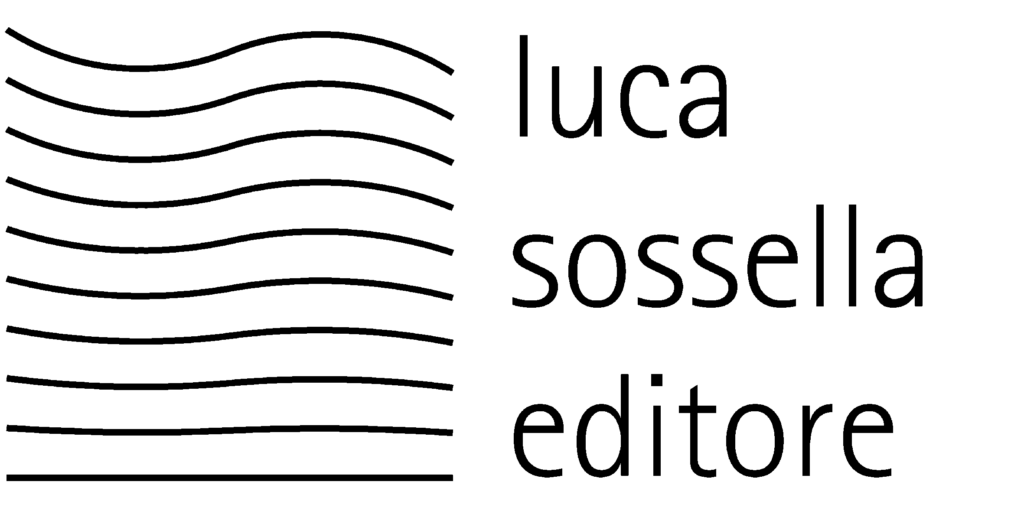“Cammina, cammina, cammina”, “sul far della sera”, il Gatto, la Volpe e Pinocchio arrivarono all’Osteria del Gambero Rosso; si posero a tavola, “ma nessuno di loro aveva appetito”. Il povero Gatto, travagliato di stomaco, “non poté mangiare altro che trentacinque triglie con salsa di pomodoro e quattro porzioni di trippa alla parmigiana”; la Volpe, poi, ridotta a “grandissima dieta”, “dové contentarsi di una semplice lepre in dolce e forte con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e galletti di primo canto. Dopo la lepre si fece portare per tornagusto un cibreino di pernici, di starne, di conigli, di ranocchi, di lucertole e d’uva paradisa e poi non volle altro.” Nell’intemporale Ottocento di Pinocchio emerge una immagine badiale, selvatica, da Boch dialettale, del mangiare italiano, anzi toscano; immagine mostruosa e domestica, come quell’osteria archetipica, campita nel mezzo di una campagna allegorica, pedagogica e maremmana. Si noterà come, da quella mensa spropositata e burlevole, uscita dalla fantasia eternamente affamata di un Pulcinella visionario, sia assente la pasta; il che, nella ideologia gastronomica italiana, significa che i personaggi con cui abbiamo a che fare sono solo perifericamente umani. Pesci e selvaggina, poi, tengono dell’abissale e del silvano, e in ogni modo connotano una terra solo avaramente umana. Ove non siano né zite, né pappardelle, né bucatini, saremo per certo in paese cimmerio, simbolico e irto.
Giorgio Manganelli